
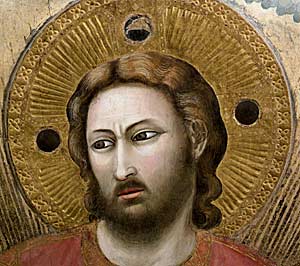 |
| Particolare del Cristo giudice nel giorno del Giudizio Universale, dopo il restauro |
La vasta composizione si
stende sull'intera controfacciata e costituisce il punto d'arrivo della
simbologia morale, del cammino di salvazione rappresentato nella Cappella.
Più che l'accentuazione mistica o il senso di orrore per le pene
dei dannati appare dominante il tema della giustizia: questa scelta è
ribadita anche dalla centralità della Virtù relativa fra
le allegorie dello zoccolo; sotto questo aspetto, è possibile istituire
un parallelo tra la visione morale proposta da Giotto e quella di Dante.
Il Giudizio di Giotto, come si diceva, è dominato dall'idea della
giustizia divina, impersonata dalla grande figura di Cristo. Con gesto
pacato ma sicuro divide nettamente due settori: a destra gli eletti; a
sinistra i reprobi, travolti da un fiume di fuoco che li fa precipitare
all'Inferno. La divisione tra bene e male è anche separazione tra
ordine e caos: gli eletti, seguendo le indicazioni degli angeli, si dispongono
in schiere regolari, mentre tra i demoni e i dannati regna la massima
confusione.
Intorno a questo nucleo tematico Giotto individua altri punti salienti.
Nella parte bassa, a sinistra, la resurrezione della carne, con i defunti
che escono dalle tombe. Segue il richiamo devozionale, con il ritratto
di Enrico Scrovegni in atto di porgere alla Vergine il modello della Cappella,
sorretto da un ecclesiastico. La Madonna è accompagnata da Santa
Caterina e Giovanni Evangelista. Il motivo dell'esaltazione della croce
introduce direttamente alla fulgente mandorla in cui è Cristo Giudice,
sorretta dagli angeli, alcuni dei quali suonano le trombe.
Di fianco sono gli Apostoli, seduti su troni; al di sopra, le compatte
schiere angeliche, un tema che diventerà molto caro alla pittura
padovana del Trecento. In alto, alle estremità superiori della
controfacciata, due angeli arrotolano la volta celeste e lasciano intravedere
i "cieli nuovi e la terra nuova" annunciati dall'Apocalisse.
Le fonti
L'iconografia del Giudizio si sviluppa, durante il Medioevo, tanto sull'evoluzione
delle immagini quanto sull' esegesi dei testi sacri. Il capitolo XXV del
Vangelo di Matteo riporta una descrizione di ciò che avverrà
alla fine dei tempi e nel momento del Giudizio: questi accenni metaforici
sono sviluppati e organizzati, in una grandiosa sequenza di episodi e
di figure nell'Apocalisse di San Giovanni. Giotto stesso ne darà
una forte e più testuale rappresentazione negli affreschi della
cappella Peruzzi in Santa Croce a Firenze. Le mistiche visioni dei santi
tramandate dalla letteratura agiografica medievale accrescono progressivamente
gli spunti figurativi: una delle fonti più importanti in proposito
è il sogno dell'abate Gioacchino da Fiore. L'affresco di Giotto
non porta sconvolgenti novità nel materiale iconografico tradizionale.
Naturalmente, da parte dell'artista si avverte un maturo e consapevole
controllo della struttura complessiva dell'immagine, ben diverso rispetto
ad altre interpretazioni forse più fantasiose ma ridotte a una
frammentaria giustapposizione di motivi grotteschi o mostruosi.
Iconografia
Il Giudizio Universale è uno dei soggetti maggiormente ricorrenti
nell'arte medievale. Frequentissimo nella scultura, dai vivaci portali
del gotico francese ai nobili e solenni pulpiti dei Pisano, il tema conta
anche alcuni precedenti in pittura. A Giotto erano certamente ben noti
i mosaici del battistero di Firenze (in cui compare, tra l'altro, la grande
figura di Lucifero in atto di sbranare alcuni dannati) e l'affresco di
Pietro Cavallini nel coro di Santa Cecilia in Trastevere a Roma. Non meno
interessante è il precedente costituito dal mosaico con il Giudizio
Universale della cattedrale di Torcello, che, come l'affresco di Giotto,
si trova sulla controfacciata della chiesa.
I numerosi rimandi figurativi, oltre alla possibilità di sbrigliare
la fantasia inventiva, specie nella zona dell'Inferno, integrano le lacune
e le contraddizioni delle fonti letterarie.